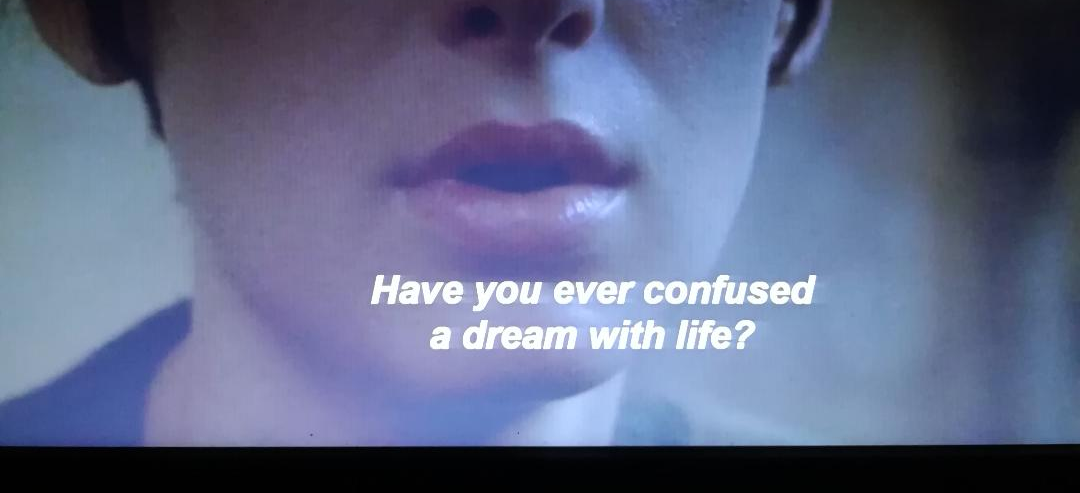Le guardi, le ascolti, e non c’è più una miss che voglia essere solo una miss. Una si è presentata con un Master in giornalismo sportivo, un’altra è iscritta a una facoltà trilingue, c’è chi si sta laureando in Scienze internazionali, chi in Filosofia, chi farà la cardiochirurga. La faccenda si fa complessa. Il passato ha sempre il pregio di essere più nitido. Chi vinceva, si faceva chiamare reginetta. Reginetta di bellezza. Era l’Italia in cui l’educazione delle bambine poteva passare dall’attesa di un principe più o meno azzurro. Te ne stavi scalza ad aspettare, lui portava una scarpetta - spesso senza citofonare - e se la misura era giusta, smack, vissero felici e contenti. Eri miss qualcosa e in fondo quella era la tua strada.
Sono saltati gli schemi. Per capirci qualcosa, bisogna arrivare in questo albergone romano oltre la via Aurelia, alla fine di una serie di collegi pontifizi, dentro una sala allestita con diciotto file di sedie dallo schienale in velluto rosso. Sarebbero tristi per un convegno di radiologi, figurarsi per la finale di miss Italia, che ai bei tempi rendeva glamour il nome di Salsomaggiore. È qui che ha chiesto asilo politico questo concorso che era un romanzone popolare, finito in esilio in un centro congressi, senza diretta tv, sulla zattera dello streaming via social, stritolato da una serie di veti perché “i valori non sono più in linea con quelli di oggi”.
È qui che bisogna venire a chiedere cosa spinga 21 ragazze scelte fra ventimila, a intrecciare i loro percorsi di emancipazione con una sfilata in passerella, dentro un costume da bagno e con un numerino sul petto. Scoperta: non sfilano più ma dialogano, indossano un abito e il numerino da fiera è stato abolito. Patrizia Mirigliani è la figlia dello storico patron Enzo. È lei che regge il gioco, allarga le braccia, dice di non sapere perché non ci sia più spazio in tv - quando in tv è pieno di ragazze uscite dal concorso. “Siamo un fenomeno di costume, non un concorso di bellezza. Se vogliamo parlare di libertà, non si può impedire a una ragazza di indossare un costume di bagno, solo per non essere etichettata come superficiale. Sulle spiagge d’estate se ne vedono di più succinti. Da miss Italia sono arrivate donne nella politica, nello spettacolo, nel giornalismo”. La vincitrice di un anno fa, Zeudi di Palma, è appena stata invitata al ministero della Cultura per la giornata del contrasto alla violenza contro le donne. E allora i valori: sono in linea o non sono in linea?
mercoledì 28 dicembre 2022
Perché vanno ancora a miss Italia
mercoledì 21 dicembre 2022
Il Marocco di Centocelle
Ora le borgate sono periferie, si somigliano tutte, sul retro di San Felice hanno dipinto un murale di Baglioni - “strada facendo, vedrai | che non sei più da solo” - perché da ragazzetto veniva a suonare la chitarra in chiesa. La parrocchia di frate Mario Fucà è diventata il centro di un corpaccione che fa 54 mila abitanti, il 18% stranieri. Se domani il Marocco dovesse aggiungere un’altra perla al suo storico Mondiale, se un gol in Qatar dovesse far ballare di nuovo tutti all’angolo di via degli Aceri, allora domenica la polenta col cous cous sarà nei piatti quando mancheranno poche ore alla finale, e a Centocelle saranno tutti sotto una stessa bandiera. Il centro di Roma è lontano 7 km. Nel 61 era un viaggio. Ora che il mondo ti entra nella vita con un telefonino, sono sei fermate di metro C che Accattone non aveva. Alla Casa del popolo in via delle Acacie, Teresa Mecca racconta dei corsi di italiano per adulti, stranieri e immigrati. “Si sono iscritti in trenta”, dice, “anche egiziani, tunisini, una siriana”. L’ambizione è aprire uno sportello che fornisca assistenza non solo burocratica, ma di partecipazione civica. “Forse le comunità sono distanti - dice frate Mario - forse non sono tutte rose e fiori, ma esiste un affiatamento tra le persone che costruiscono ponti e aggregazione. Qui non ci sono mai stati episodi di intolleranza, neppure di rifiuto reciproco. Se vogliamo vivere in pace, dobbiamo scommettere sulla valorizzazione della diversità. Mi pare che la comunità musulmana gradisca quest’attenzione”.
giovedì 15 dicembre 2022
La magia che Marco D'Amore vede in Napoli
C'è un uomo esageratamente anziano accecato da una luce in uno scrigno. L'ha aperto con le mani che tremano per l'età, per la fatica di una ricerca. Ha percorso i sentieri di tufo del sottosuolo, si è tuffato nel golfo, ha visto spiriti e fantasmi. Ha pure baciato una sirena, non una qualunque, Partenope, per capire da dove vengano miti e leggende della città. Marco D'Amore è stato al trucco sei ore, prima di girare la scena chiave del suo film Napoli magica, nei sotterranei di Castel dell'Ovo, dove Virgilio nascose l'uovo su cui si posano l'edificio e la città, guai a romperlo, sarebbe una sciagura.
«È un progetto che mette in scena un fallimento — dice — l'impossibilità di raccontare Napoli nella sua pienezza. Come ogni città-mondo ». Prodotto da Sky e Mad Entertainment, il film sarà fuori concorso al festival di Torino, in sala tre giorni dal 5 dicembre, con un linguaggio a metà tra documentario e finzione. È un viaggio nelle credenze di Napoli e dentro ciò che di Napoli si crede, nelle convinzioni dei vivi e nel culto dei morti, un'indagine su Storia e percezione, complessi di superiorità e inferiorità, sul misterioso bisogno di affetto e la necessità di piacere, sulla separazione tra élite e popolo, in un posto dove stanno insieme l'illuminismo di Vico e il corno rosso della superstizione. Ed è curioso che questo percorso nell'aldilà lo faccia il volto che in Gomorra era l'Immortale.
«È il mio desiderio di conoscenza, una spinta che sento da ragazzino. Sono andato via a 18 anni, sono tornato a 30. Ho studiato a Milano, ho girato il mondo con la compagnia di Servillo. Mamma mi portava al Duomo, papà allo stadio. Sono le due passeggiate che mi hanno formato, ma il volto meno folkloristico di Napoli si conosce poco, anche in città. Pasolini ci chiamò una tribù che ha deciso di estinguersi, eppure esiste qui una spinta alla modernità e al progresso. Pazienza se mi sento contestare di non mettere distanza tra me e un'eredità artistica di cui non ho alcun merito, di essere troppo napoletano nel punto di vista politico».
Tra il cimitero delle Fontanelle, le catacombe di San Gaudioso e la cappella del Cristo Velato, il film è un atto di devozione. Eppure, D'Amore tradisce il piacere di camminare nei risvolti, sui sentieri della Napoli scientifica. Mette in scena l'afasia del popolo incapace di definire cosa siano magia e bellezza. Chiude con una sorpresa, uno sberleffo tra Collodi e Apuleio in cui pare invocare una moratoria, il silenzio dell'ignoranza su Napoli. C'è tanto studio dell'antropologia cittadina in dettagli, eccessi, scene comiche, omaggi a Totò e Peppino.
lunedì 12 dicembre 2022
La Roma di Ornella Vanoni
La giovane Ornella che aveva preso il diploma per fare l’estetista perché «avevo l'acne», si ritrovò cucita sulla pelle l’etichetta di cantante cerebrale. Nei titoli era accostata spesso così a Laura Betti, capace d’essere insieme sia felliniana sia pasoliniana, oltre che attrice preferita di Bellocchio. L’Ornella delle Mantellate sparì presto dalla scena. Divenne quasi subito molto altro, si diede alla prosa, al cinema, alla musica leggera. Roma ebbe di nuovo un ruolo, venne per sposare l’impresario Lucio Ardenzi, uscendo dalla figura politicamente scorretta di cantante della mala, quelle esibizioni che erano state raccontate dai critici del 1959 come una “apparizione espressionista, cantava guardando il soffitto, pallida, gli occhi brucianti, le mani bianchissime e lunghe nelle nella semioscurità della sala”.
martedì 22 novembre 2022
Storia dei Musumeci Greco, maestri di spada degli attori
Se c’è un film di cappa e spada, è qui che gli attori vengono a imparare, nel cuore di Roma, una cinquantina di passi dal Pantheon. Cominciò Gino Cervi, anno 1939. Prima di essere Maigret, Alessandro Blasetti gli diede il ruolo del pittore Salvator Rosa, nella leggenda Formica, abilissimo spadaccino mascherato contro il conte Lamberto, consigliere del viceré di Napoli. Gli fece da maestro Enzo Musumeci Greco, nipote di Aurelio e Agesilao. La loro Accademia d’armi in via del Seminario, logo di Duilio Cambellotti, esiste dal 1878. Sono passati Tyrone Power per “Il Principe delle Volpi” e Orson Welles per “Cagliostro”, poi Richard Burton, Charlton Heston, Burt Lancaster.
“Questo è papà con Errol Flynn”, dice Renzo Musumeci Greco, sfilando una cornice da un mucchio di foto. È la quarta generazione dei maestri che insegnano l’arte del duello prima dei ciak. Per la Festa del cinema tiene oggi un corso intensivo di 6 ore a 12 giovani attori. “Ragazzi in attesa di qualche provino. Intanto imparano che cos’è una parata, un affondo, un passo avanti. È come quando un professore di piano insegna - che so - a fare una canzone di Battisti. Come può uno scoglio arginare il mare”.
La scherma è una successione di gesti come al piano?
“Ci sono produttori che chiamano e dicono: ahò, te damo tre giorni. In genere rispondo: vieni tu e vediamo se in tre giorni impari. Questi film scalcagnati li riconosci dal montaggio vertiginoso, inquadrature strette. Nessuno impara niente. Magari ci sono io che infilo un braccio. Quando invece abbiamo fatto Caravaggio, con la fotografia di Storaro, le lezioni sono durate tre mesi. I duelli erano senza controfigure con 100 colpi da ricordare a memoria, più la sicurezza da garantire. Per L’innocente di Visconti, 120 colpi in piano sequenza, i tempi sarebbero stati perfino più lunghi. Truccarono me e mio fratello e combattemmo. Oggi esistono i trucchi del digitale. Dalle lame di Sean Connery e Richard Gere, ne “Il Primo Cavaliere” uscivano stelle filanti, come comete. Significa che sul set non avevano niente in mano. Tutto finto. Invece Johnny Depp nel “Pirata dei Caraibi” si è mosso più lentamente e hanno velocizzato l’azione dopo”.
domenica 30 ottobre 2022
Il gol che Turone non ha smesso di segnare
Cosa accadde quel giorno si sa. Il guardalinee Giuliano Sancini, negoziante di abbigliamento sportivo e articoli da regalo a Bologna, annullò per fuorigioco il gol che avrebbe dato alla Roma di Liedholm il suo scudetto con due anni d’anticipo. Giusto, sbagliato, e chi lo sa. Carlo Sassi alla Domenica Sportiva non riuscì a stabilirlo in modo definitivo, il martedì la Gazzetta scriverà che “alla moviola è parso regolare”. Tutti a Roma sanno dov’erano e cosa facevano, quella domenica. Di questo si occupa il film, “di come una città - spiega Pecorelli - si lega a un fenomeno, il calcio, di come continua a vivere un episodio accaduto nel 1981 come se fosse ieri”. Con un registro ironico e brillante, con le testimonianze di Falcao, Pruzzo, Prandelli, Marocchino, di arbitro e guardalinee, di tifosi noti e soprattutto tifosi comuni. L’ambizione di “Er gol de Turone era bono”, spiega Pecorelli, è quella di ritrarre “una giornata particolare del tifo, l’attesa, la preparazione, l’esodo senza charter”, fino al dopo, quando Vanzina dice che nasce la leggenda del romanismo piagnone.
venerdì 28 ottobre 2022
La città che insegna a fare il cinema
Alessandra Rucco invece lavora in qualunque condizione, in riva a un fiume, in un bosco in Norvegia. Fa la segretaria di edizione e dice che ancora oggi, dopo vent’anni, qualcuno crede abbia a che fare con gli accenti. La dizione. Invece è il ruolo in cui si registra l’attività giornaliera del set, le sequenze, i ciak, i commenti del regista, un diario di bordo che sarà utile al montaggio. Ha scoperto il mestiere quasi per caso. Faceva la comparsa nella serie La Squadra. “Il cliché culturale - spiega - vuole che si tratti di un lavoro per donne. Forse perché serve un approccio femminile, forse per il nome”. In America lo chiamano script supervisor, Ambra Angiolini suggerisce: direttrice della continuità. Rucco ha una sua piattaforma online per la formazione, tiene corsi avanzati e per principianti.
giovedì 27 ottobre 2022
Gli anni di piombo raccontati da chi non c'era
Studiano per fare del cinema il loro futuro all’istituto Roberto Rossellini, liceo artistico con indirizzo audiovisivo. Intanto hanno portato al Maxxi e alla Festa del Cinema un prezioso lavoro, “Divergenze parallele”, titolo che parafrasa e sovverte la formula politica delle convergenze usata da Aldo Moro - con la regia di uno dei loro docenti, Massimo Franchi. Quindici anni della vita di Roma raccontati da chi passa davanti alla stele di Giorgiana Masi senza conoscere la sua storia, la sua e quella di una generazione che ha subito “un furto di tempo, dell’allegria e della speranza”, come dice Walter Veltroni, l’ex sindaco, uno degli intervistati dai tre protagonisti del film, ai quali racconta “la violenza diffusa, la sensazione che potesse sempre succedere qualcosa”, gli anni barbari, la diffusione della droga, una partita di pallone giocata ai giardinetti con uno dei futuri responsabili del rapimento di Moro e dell’omicidio della scorta. Quando la città era bianca e nera, dice la voce narrante di Tiziano Favaretto: bianca per i lacrimogeni, nere per le auto in fiamme.
mercoledì 26 ottobre 2022
Il cinema dentro Rebibbia
 Oltre il rosso matto della guardiola, una volta chiuso il cancello alle spalle, ci sono diciotto scalini da scendere, lasciandosi sulla destra il braccio G12 e la sala per i colloqui, prima di entrare in un teatro da 340 posti, dove a Rebibbia si tramanda il ricordo della più fulminante recensione mai ascoltata: “‘A Infasce’, manco quanno è nato mi fijo ho pianto così”. Alex Infascelli, regista di Mi chiamo Francesco Totti, passò così l’esame della platea più esigente di Roma e dintorni, i 1600 detenuti tra Ponte Mammolo e la Tiburtina, cinque minuti a piedi da quella piazza Ferriani dove per un po’ visse Pasolini. Una comunità di persone che se spende un paio d’ore davanti a uno schermo, non vuole gettarle via. Non ha tempo da sprecare e non può chiamarlo tempo libero. Quando un regista porta un suo film dentro il Teatro Libero di Rebibbia, scopre il petto al vento, misura quanta distanza ha messo tra la sua arte e la sincerità. La Fondazione Cinema per Roma contribuisce a costruire il cartellone. Ieri la Festa ha portato in anteprima L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido. Due ore di buio e di silenzio teso, per la storia di papa Papa Paolo V che mette un uomo dei servizi a seguire il pittore condannato a morte per omicidio. Deve capire se può concedergli la grazia.
Oltre il rosso matto della guardiola, una volta chiuso il cancello alle spalle, ci sono diciotto scalini da scendere, lasciandosi sulla destra il braccio G12 e la sala per i colloqui, prima di entrare in un teatro da 340 posti, dove a Rebibbia si tramanda il ricordo della più fulminante recensione mai ascoltata: “‘A Infasce’, manco quanno è nato mi fijo ho pianto così”. Alex Infascelli, regista di Mi chiamo Francesco Totti, passò così l’esame della platea più esigente di Roma e dintorni, i 1600 detenuti tra Ponte Mammolo e la Tiburtina, cinque minuti a piedi da quella piazza Ferriani dove per un po’ visse Pasolini. Una comunità di persone che se spende un paio d’ore davanti a uno schermo, non vuole gettarle via. Non ha tempo da sprecare e non può chiamarlo tempo libero. Quando un regista porta un suo film dentro il Teatro Libero di Rebibbia, scopre il petto al vento, misura quanta distanza ha messo tra la sua arte e la sincerità. La Fondazione Cinema per Roma contribuisce a costruire il cartellone. Ieri la Festa ha portato in anteprima L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido. Due ore di buio e di silenzio teso, per la storia di papa Papa Paolo V che mette un uomo dei servizi a seguire il pittore condannato a morte per omicidio. Deve capire se può concedergli la grazia.
Dentro le carceri, un tempo il cinema veniva a girare i suoi film e quando spegneva le luci, se ne andava. Da Rebibbia non esce più. È un ponte con l’esterno. Paolo Taviani è tornato giorni fa a dieci anni di distanza da “Cesare non deve morire”, premiato a Berlino e girato con una ventina di detenuti per attori. C’erano quasi tutti alla rievocazione, da uomini liberi. Il Centro Studi Enrico Maria Salerno cura quotidianamente la promozione di attività teatrali, cinematografiche, editoriali. Fabio Cavalli dirige e coordina. Sei anni fa portarono il cortometraggio Naufragio con spettatore alla Mostra di Venezia. “Non dobbiamo formare attori - dice - ma tenere accesa una luce. Gli effetti dell’arte nelle carceri è misurabile. La recidiva nel reato di chi frequenta un percorso di recitazione o di musica scende al 10 percento, rispetto alla media del sessantacinque. Qui il lockdown è stato più feroce che altrove. Tutte le iniziative si sono fermate. Riallacciare un filo è stato difficilissimo”.
martedì 25 ottobre 2022
Il western di Cristina Comencini
Puoi rifare il western ma non toccare Pinocchio. Puoi accettare la sfida di essere tra le poche donne al mondo a confrontarsi con il genere cinematografico della virilità, ma i confronti con i padri sono un’altra cosa. Più impegnativa. Più profonda. Su un coloratissimo divano nel cuore del quartiere San Lorenzo, Francesca Comencini ne è divertita. Sgombra il campo dagli imbarazzi. “Starei delle ore a parlare di Pinocchio, ma non ne girerei mai una versione mia. Non mi azzardo. Spero che qualcuno osi ancora, altri lo hanno già fatto. Non io. Proprio non posso”. C’è un filo tra l’eroe di legno che papà Luigi portò cinquant’anni fa nelle case degli italiani con Manfredi-Geppetti e il suo Django, l’anti-eroe della serie prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions, in anteprima alla festa di Roma. “Pinocchio, come il western - dice Francesca Comencini - non finirà mai”.
Una volta Paolo Virzì ha raccontato di aver saputo in treno da Matteo Garrone che stava per girare Pinocchio, mentre lui stesso aveva una riunione in settimana su un progetto simile. Chiamò la segretaria e annullò. Perché tutti vogliono fare un Pinocchio?
“Perché è un contenitore smisurato che rappresenta la condizione umana, in modo universale. Ognuno ne ha uno suo. Quale sia il mio preferito è ovvio. È un enorme archetipo, il mondo di qualunque essere umano si sia sentito storto da bambino, con la sensazione di sentirsi bruciare qualcosa. Come ogni classico, parla di oggi. In questo senso, Pinocchio è un western”.
Se ne vedevano molti in casa Comencini?
“Onestamente, non credo che a papà piacessero. Le favole, quelle sì. Il western era una passione soprattutto mia, da adolescente ribelle. Erano gli anni in cui si andava al cinema per vedere i film di Sergio Leone, “Piccolo grande uomo” o “Pat Garrett e Billy the Kid”. Incarnavano lo spirito del tempo meglio di quei film di denuncia che andavano dritti. Il western è il genere-manifesto dell’idea di chi non si sottomette”.
lunedì 24 ottobre 2022
Come Roma racconta al cinema i suoi ultimi
Quando nel luglio del ‘58 Alberto Moravia pubblica sul Corriere della sera un racconto che si chiama L'incantesimo, Pier Paolo Pasolini ha esordito con Ragazzi di Vita da tre anni. Lo hanno mandato a processo per oscenità e s’è salvato con la testimonianza di Carlo Bo, perché il romanzo - ha detto in tribunale - “spinge alla pietà verso i poveri e i diseredati". Moravia attaccherà la sua storia scrivendo: "Gli zingari che stanno nelle baracche del Mandrione, vicino a Porta Furba, sono diversi da noialtri romani". Diciassette parole. La rappresentazione di un muro. La linea che separa la città ufficiale dagli ultimi, i giusti dagli espulsi. Siamo alla vigilia di Accattone, il film che apre la stagione delle indagini del cinema nelle esistenze degli irrilevanti, tra Pietralata e il Quarticciolo, dove certe volte si può avere nostalgia solo della morte. Il neorealismo aveva scoperto i proletari, Pasolini mostrerà che c’è un altro strato, un pezzo di mondo che sta di sotto.
Non solo metaforicamente, in questo sotto vivono due nuovi ultimi del cinema italiano, si chiamano Romeo e Callisto, e sono destinati a rimanere indimenticabili con la loro disperazione in Bassifondi, film d’esordio di Trash Secco, con la sceneggiatura poetica di Fabio e Damiano D’Innocenzo, prodotto da 11 Marzo Film con Rai Cinema. Abitano gli argini del Tevere e la città di sopra li ha dimenticati. Hanno le forme opposte di Gabriele Silli e Romano Talevi, alto e magro il primo, riservato, taciturno; basso e irregolare l’altro, sboccato, repellente, l’ultima coppia shakespeariana partorita dalla periferia romana, una catena cominciata con Scintillone e Ruggeretto di Bolognini ne La Notte Brava, ma qui senza nessun compiacimento estetico.
Sono lo scarto degli scarti, emarginati nella stessa comunità dei senzatetto, fanno i bisogni in strada come i cani randagi, mangiano come i gabbiani del degrado, si trovano pancia a terra come il topo che scende le scale e annusa i cartoni, attraversa la monnezza, si strofina contro i piedi di chi dorme sotto i ponti. Salgono nella città di sopra per attaccare il naso e le labbra alla vetrina del Caffè della Scala, guardano come i borghesi mangiano i cornetti e si tolgono le briciole dalla barba. Questa secca dell’esistenza è una fantasia partorita da Trash Secco quindici anni fa, prima che Claudio Caligari mettesse in scena tra Ostia e Fiumicino le dipendenze di Cesare (Luca Marinelli) e Vittorio (Alessandro Borghi) in Non essere cattivo. La dipendenza di cui parla Bassifondi è quella dal calore delle persone. “Una storia di fratellanza e d’amore platonico con un compagno d’avventure” dice il regista. Durante le riprese, suo padre gli ha regalato il dvd del film di Kurosawa che porta lo stesso titolo, “e sul set ce lo ripetevamo spesso, facciamolo alla Kurosawa, nel senso che spesso il teleobiettivo stava lontano dagli attori, quasi a spiarli”.
È dalla metà degli Anni Settanta che il mondo degli ultimi lo diciamo dei brutti, sporchi e cattivi, facendo del titolo di Ettore Scola un‘etichetta. Lo puoi raccontare pure se vieni da Prati. Solo che la sincerità si vede. I gemelli D’Innocenzo sono partiti col loro cinema da un set a Ponte di Nona. Quattro anni fa La terra dell’abbastanza era stata un’immersione in un posto senza una scuola, senza una fermata del treno, senza un parco - un posto dove Mirko e Manolo erano due isole affettive condannate al sacrificio. Cinque Nastri d’argento dopo, con il premio di Berlino alla sceneggiatura di Favolacce, Damiano racconta che prima di scrivere Bassifondi ha voluto rileggere Fame di Knut Hamsun, “per ritrovare quella disperazione che - senza essere falsi - abbiamo perso. Trash Secco conosce la grazia degli ultimi e la malinconia dei primi. È un magnifico illustratore. Frequenta il basso senza paura e lo racconta da lì”.
Fabio dice di non aver avuto “libri sul comodino davanti a me, ma la finestra, la gente fuori, e in casa ho pure qualche specchio. Non ho fatto fatica, casomai ho provato vergogna nell’essere tra quelli che ogni tanto pensano di non appartenervi”. L’imperatore di Roma di Nico D’Alessandria è il film di cui Bassifondi si sente più parente. C’è stato un tempo in cui la periferia romana era oltre le mura, poi è stata inghiottita dentro la città che avanza, ora è trasversale. Quando la morte schiaccia Accattone, gli sentiamo dire “Ah! Mo’ sto bbene”, come Callisto accanto a Romeo mormora di non avere niente, eppure ha tutto.
[uscito su Repubblica Roma il 17 ottobre 2022]
domenica 23 ottobre 2022
Fenomenologia del Gradasso romano
Arriva adesso un ultimo aggiornamento che porta la faccia di Marco Giallini ne Il Principe di Roma, passato in anteprima ieri alla Festa dell’Auditorium, dal 17 novembre in sala, distribuito da Lucky Red, che co-produce con Rai e Sky. È un tipo che punta a comprarsi un titolo attraverso il matrimonio con l’erede di una nobiltà spiantata, portando - lui - in dote 100 scudi. Parla la lingua nota dei mattatori di Roma. Quando all’ex amico di gioventù dice “Io so’ diventato principe e tu sei rimasto co’ ‘e pezze ar culo” fa sentire tutta l’eco del Sordi vestito da Marchese del Grillo, quello che io so’ io, eccetera eccetera. Se non fosse in abiti ottocenteschi, potrebbe passare per uno dei flâneur visti sullo schermo dentro il corpo di Vittorio Gassman, da Bruno Cortona in poi (Il Sorpasso, Dino Risi, 1962), il prototipo di un certo modo affascinante di essere laido. Edoardo Falcone, regista e sceneggiatore del Principe di Roma, dice di aver scritto il suo film pensando al mondo di Luigi Magni (“Una scelta obbligata”), un mondo popolano e popolare che ha mescolato i propri passi con il clima e l’umore della commedia dell’arte, con la radice originaria del poema cavalleresco. L’antonomasia del Gradasso viene dagli Orlando di Boiardo e Ariosto, uno innamorato e l’altro furioso. Porta quel nome uno dei capi saraceni e l’ha lasciato in eredità, come aggettivo, alla folta schiera di maschere romane, che si tratti di un Meo Patacca, oppure del suo alter ego Marco Pepe, lo spaccone, il fanfarone che promette sfracelli e scappa, un poco vigliacco, un poco canaglia, comunque plateale. Rugantino è la versione addolcita, Cacini quella sguaiata.
sabato 22 ottobre 2022
Come parlano i romani al cinema
Il Signore degli Anelli si è inventato l’elfico, Avatar ha fatto conoscere il Na'vi, due latiniste hanno lavorato per aggiungere la lingua di Romolo a quella di Sordi e Fabrizi. Hanno ricostruito un latino che non si studia nelle scuole, ma con una base scientifica. Si sono date un metodo comparativo tra lingue indo-europee, cercando un carattere comune a strutture affini. Daniela Zanarini spiega che “non è la lingua colloquiale né la lingua aulica dei re, si tratta di un grosso compromesso, un lavoro di immaginazione sulla base di una filologia corretta”. Gianfranca Privitera, sua compagna in questa fantasia colta e pop, racconta che “il sapere andava usato e tacitato, per costruire una lingua precedente a quella che conosciamo.
Bisognava cercare il senso della distanza, un latino che fosse rappresentazione del pensiero magico del tempo”. Romolo ha dato una mano. Se è vero che offrì asilo a quanti volevano vivere in Roma, compresi lazzari e assassini, la sua lingua non poteva che essere un impasto di prestiti, “il lessico dei naviganti - dicono le docenti - degli emigranti in una Roma mossa e irrequieta, la lingua della commistione e della mescolanza”. Hanno usato la struttura paratattica del greco di Omero. Hanno privilegiato i suoni forti e duri, quelli che al nostro orecchio sembrano arcaici. Si sono poste il problema di “come far parlare una comunità rozza, probabilmente priva di un pensiero articolato, con frasi semplici, senza subordinate, nelle quali il concreto prevale sull’astratto”, ma con esigenze di sceneggiatura, con “la presenza di personaggi complessi che conoscono odio, gelosia, elaborano un senso del divino”. Un processo di immaginazione fonetica.
venerdì 21 ottobre 2022
Nuovo Cinema Flaminio: le sale che hanno chiuso nella zona del festival
lunedì 14 marzo 2022
La leggerezza di WIlson, il capitano baronetto
 Successe a Sunderland, a Doncaster, a Wolverhampton, a Londra per una partita contro l'Arsenal nel vecchio stadio di Highbury e pure davanti al mare di Ipswich. Ogni volta che la Lazio volava in Inghilterra, Pino Wilson si trovava a fissare l'orizzonte e a fare i conti con una tentazione, scappare, salire su un treno, esplorare. Desiderava vedere finalmente Darlington, almeno una volta, su al nord, dove tra carbone e acciaio erano diventati famosi per la lana e per la prima ferrovia al mondo. Voleva risalire alle radici, scoprire la sua culla, era nato là e non c'era tornato mai. Era di quella Lazio il volto della saldezza, portava la fascia da capitano, ma aveva pure lui le sue malinconie. Suo padre Denis, inglese, aveva fatto il militare a Napoli, la città dove si era innamorato di Rachele. Dentro uno spogliatoio che aveva assegnato a ciascuno un ruolo, Wilson era il dominus d'ogni contesto, era l'altra faccia di Chinaglia, la sua spalla forte, almeno fino alla crisi post scudetto che portò Giorgione in America e la squadra dei miracoli a smembrarsi. Luigi Martini aveva la parte dell'oppositore, Sergio Petrelli quella dell'irregolare che aveva portato le pistole dentro lo spogliatoio, Renzo Garlaschelli il viveur, Mario Frustalupi il filosofo socialista, Felice Pulici un buono agostiniano, Franco Nanni il timido, Vincenzo D'Amico la recluta, Giancarlo Oddi l'ingenuo, Mario Facco una specie di fool shakespeariano. Wilson era invece per tutti il Baronetto, per altri il Padrino. Proiettava questa posa di stabilità e di fermezza pure sul campo. Quando Gianni Brera se ne avvide, di lui scrisse: «La difesa ha scoperto in Wilson un regista sapiente, non che sia gran cosa l'anglo-napoletano, in fatto di acrobazia: è anche miope e sulle palle spioventi da lontano non si sente a suo agio, come è ovvio: però nel tackle è tempestivo e qualche volta maligno. Nei disimpegni tocca di piatto destro con ricercata eleganza».
Successe a Sunderland, a Doncaster, a Wolverhampton, a Londra per una partita contro l'Arsenal nel vecchio stadio di Highbury e pure davanti al mare di Ipswich. Ogni volta che la Lazio volava in Inghilterra, Pino Wilson si trovava a fissare l'orizzonte e a fare i conti con una tentazione, scappare, salire su un treno, esplorare. Desiderava vedere finalmente Darlington, almeno una volta, su al nord, dove tra carbone e acciaio erano diventati famosi per la lana e per la prima ferrovia al mondo. Voleva risalire alle radici, scoprire la sua culla, era nato là e non c'era tornato mai. Era di quella Lazio il volto della saldezza, portava la fascia da capitano, ma aveva pure lui le sue malinconie. Suo padre Denis, inglese, aveva fatto il militare a Napoli, la città dove si era innamorato di Rachele. Dentro uno spogliatoio che aveva assegnato a ciascuno un ruolo, Wilson era il dominus d'ogni contesto, era l'altra faccia di Chinaglia, la sua spalla forte, almeno fino alla crisi post scudetto che portò Giorgione in America e la squadra dei miracoli a smembrarsi. Luigi Martini aveva la parte dell'oppositore, Sergio Petrelli quella dell'irregolare che aveva portato le pistole dentro lo spogliatoio, Renzo Garlaschelli il viveur, Mario Frustalupi il filosofo socialista, Felice Pulici un buono agostiniano, Franco Nanni il timido, Vincenzo D'Amico la recluta, Giancarlo Oddi l'ingenuo, Mario Facco una specie di fool shakespeariano. Wilson era invece per tutti il Baronetto, per altri il Padrino. Proiettava questa posa di stabilità e di fermezza pure sul campo. Quando Gianni Brera se ne avvide, di lui scrisse: «La difesa ha scoperto in Wilson un regista sapiente, non che sia gran cosa l'anglo-napoletano, in fatto di acrobazia: è anche miope e sulle palle spioventi da lontano non si sente a suo agio, come è ovvio: però nel tackle è tempestivo e qualche volta maligno. Nei disimpegni tocca di piatto destro con ricercata eleganza».